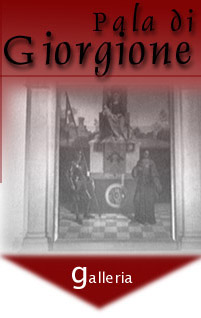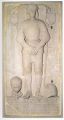La Madonna
di Castelfranco, raffigurante "Maria in trono tra i santi", Francesco
(protettore di casa Costanzo) ed un guerriero in armatura con orifiamma
(un tempo creduto Liberale, quindi Giorgio e da ultimo Nicasio,
protettore dei cavalieri dell'ordine di San Giovanni, di cui il
committente fu l'Ammiraglio) fu dipinta da Giorgione, intorno all'anno
1505.
L'occasione della sua fattura risale ad un lutto. Un giovinetto
diciottenne, già condottiero di cinquanta lance a gli ordini della
Repubblica, era morto nel 1504. Fu questi Matteo Costanzo, figlio di un
illustre e nobile famiglia, dimorante in Castelfranco.
La famiglia Costanzo abitò dentro le mura del castello, della casa in
vicolo del Paradiso, confinante con quella dei Barbarella. Il padre ebbe
un affetto singolare nel ricordo verso il proprio caduto. Ornò di un
altare nuovo (nella Chiesa Vecchia di dentro) la propria cappella
gentilizia; a sigillo della tomba terragna pose una lapide con
l'immagine rilevata del figlio e chiamò Giorgione, il pittore di maggior
fama di Venezia, perché raffigurasse "l'amore materno di Maria" su di
una tavola, con una visione di paese e figure di guerrieri nello
sfondo.
È nuovo il concetto di una tomba che, inserendosi nella prospettiva di
una tavola dipinta, si illumina della luce effusa dal paesaggio
figurato. La conversazione di Maria con i santi si concentra in un punto
che è fuori dal quadro; è la salma adagiata sul marmo che chiude il
sepolcro. Il quadro richiama uno spazio più ampio: gli sguardi
convengono in una meditazione pietosa verso il giovane morto. Il
complesso della cappella Costanzo è arioso ed armonico.
Così si intuisce anche l'esigenza dell'affresco sulla volta che
contrappunta la conversazione tra il mondo figurato ed il mondo reale,
cioè la tomba. Si tratta di una figurazione di ambiente che coinvolge le
cose nella luce: novità agli occhi degli uomini che assistono ad una
veglia mortuaria. Il tema della sepoltura diventa spaziale. E mentre il
soggetto della morte, cui gli occhi dei conversanti si concentrano, è
fuori del quadro, nel paesaggio, al di là della coltre rossa, analoghi
motivi di realtà instabili sono dipinti, per contrappeso, come le case
dirute, le torri cadenti, i cascinali consunti, gli stagni a fiore di
terra, dove il principio del vivere si unisce al suo aspetto di
opposizione, in una dialettica di decadimento e resurrezione.
La cappella scomparve con la demolizione della Chiesa Vecchia nel 1723.
L'iscrizione sulla pietra tombale di Matteo Costanzo rievoca, nella sua
epigrafe, le fattezze corporee del figlio, coerenti alle virtù del suo
animo.
Questa lapide, un tempo adagiata a sigillo della tomba pavimentale, ora
è murata sulla parete sinistra della cappella nuova del Duomo. Le sorti
della "Pala" seguirono le alterne vicende dei tempi. Per questo si dovè
ricorrere a molteplici restauri. Se ne ricorda uno, eseguito
dall'estroso pittore Vecchia nel 1674; una successiva saldatura fu
effettuata dal Medi del 1731 con modifiche del paesaggio e del santo
guerriero.
Il restauro del Balzafiori del 1803 curò guasti e tolse aggiunte
capricciose di precedenti ritocchi. Seguirono altri interventi, finché
nel 1934 la Pala ebbe un definitivo restauro ad opera di Mauro
Pelliccioli che restituì nella sua integrità l'intero paesaggio. Il
dipinto dischiude in Venezia l'era della pittura, cioè la costruzione
delle immagini con il solo calore, che è l'apparire delle cose nella
luce, dove ogni realtà è comunicante, partecipe di un'emozione
universale.
L'insegnamento non poteva altro che procedere da Venezia, perciò anche
da questa Pala di Castelfranco: esso è stato il linguaggio figurale che
tosto si diffuse nell'Europa stupita e nel mondo. Nel settembre del 1935
la Madonna del Giorgione ebbe la sua nuova sede.
Una cappella fu aperta nell'edificio del Duomo, a cura della
Soprintendenza ai monumenti di Venezia. La cappella è semplice, aperta
con due finestruole, con pancate e dossali di noce ai lati. Un altare di
pietra chiara, con cornice dello stesso materiale, con i capitelli e
architrave, racchiude il dipinto. La sobrietà architettonica e
decorativa dona risalto alla pittura.
|